Piano di pace per l’Ucraina: perché l’Europa non l’ha mai voluto e non sa come costruirlo
- Max RAMPONI
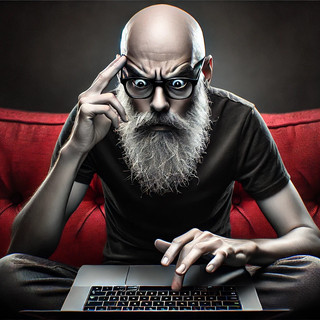
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min

Quando Donald Trump ha annunciato che avrebbe potuto chiudere la guerra in Ucraina in “24 ore”, l’Europa ha reagito con la stessa smorfia di chi teme più la rivelazione della propria irrilevanza che l’esagerazione di chi parla. Il punto non era la sparata in sé, né la teatralità con cui Trump la proponeva, né il suo stile da venditore globale; il punto era che lui un’idea, un piano di pace per l’Ucraina, l’aveva messa sul tavolo, mentre l’Europa non ne aveva uno, non ne aveva mai discusso seriamente e soprattutto non sapeva nemmeno da dove cominciare per costruirlo. La semplice enunciazione di un possibile piano, anche solo come bozza, diventava un atto destabilizzante perché costringeva a guardare in faccia un vuoto che il continente aveva preferito ignorare. In un’Unione dove la parola “pace” è stata trasformata in un valore morale da esibire più che in un percorso politico da costruire, l’offerta di un outsider d’oltreoceano diventava uno specchio troppo lucido: restituiva l’immagine di leader che parlano di principi ma non producono strategie, che evocano scenari ma non costruiscono processi. L’Europa si è sentita messa in discussione non dal contenuto del piano di pace per l’Ucraina, ma dall’idea che qualcun altro, fuori dal suo perimetro, potesse anche solo provarci. La reazione è stata immediata, quasi istintiva: minimizzare, ridicolizzare, respingere.
Non perché la proposta fosse insensata, ma perché mostrava ciò che i governi europei non vogliono ammettere pubblicamente: il continente più esposto al conflitto non ha una visione propria su come fermarlo. Trump ha toccato un nervo scoperto senza nemmeno volerlo; ha rivelato quanto la UE sia prigioniera della sua incapacità strutturale di trasformare la retorica pacifista in un’iniziativa concreta. Il problema non è Trump. Il problema è che è bastata una frase per far crollare la pretesa europea di essere custode della pace senza avere, né ieri né oggi, gli strumenti per costruirla davvero.
Da Berlino è arrivato il solito vuoto pneumatico travestito da responsabilità: prima Olaf Scholz, maestro dell’indecisione computata, capace di trasformare ogni scelta in un’agonia; poi Friedrich Merz, che ha ereditato una Germania stanca, divisa, e soprattutto paralizzata da una paura di sbagliare più forte della volontà di guidare. Emmanuel Macron ha continuato la sua danza a zig-zag, un giorno stratega solitario che sogna l’autonomia europea, il giorno dopo fedelissimo dell’ombrello NATO, il giorno dopo ancora improvvisato mediatore con Putin, senza risultati tangibili. Ursula von der Leyen ha assunto un ruolo da comandante morale del fronte occidentale, tutta disciplina e annunci granitici, ma senza aver aperto un solo vero corridoio diplomatico. Charles Michel ha incarnato la perfetta rappresentazione della burocrazia europea: presente, elegante, verboso, irrilevante. Josep Borrell ha ridotto la diplomazia a un repertorio di metafore, parlando dell’Europa come “giardino” circondato da “giungle”, dimenticando che la diplomazia esiste proprio per evitare che la giungla si mangi il giardino e che il giardino strangoli la giungla.
A Est, Viktor Orbán ha giocato il ruolo del provocatore che critica tutto senza proporre niente, incontrando Putin non per cercare una pace, ma per guadagnare margine politico interno. I polacchi, guidati da Donald Tusk, hanno assunto una postura da guardiani della frontiera della civiltà occidentale, falchi per memoria storica prima ancora che per strategia, incapaci tuttavia di immaginare un percorso che contempli dialogo, tregue, compromessi. Nel Regno Unito, prima Boris Johnson che trasformava la guerra in un palcoscenico personale, poi Rishi Sunak che non ha lasciato alcuna impronta strategica, e infine Keir Starmer che pensa più a riordinare Westminster che a ridefinire il ruolo britannico nel continente: tre fasi diverse, nessuna visione autonoma.
La NATO ha mantenuto lo stesso copione: Jens Stoltenberg, per anni, ha ripetuto lo stesso mantra — vittoria sul campo, niente dialogo, linea dura — con l’inflessibilità di un metronomo, e Mark Rutte, subentrato, ha proseguito lungo lo stesso binario, confondendo la fermezza con l’assenza di immaginazione.
E poi c’è l’Italia, eterna comparsa che si crede protagonista. Mario Draghi ha mantenuto una postura impeccabile da manuale occidentale — totale allineamento alla linea USA, nessuna apertura autonoma, zero tentativi reali di mediazione — troppo impegnato a tenere in piedi un paese sgangherato per permettersi deviazioni diplomatica. Giorgia Meloni ha ereditato quella linea e l’ha irrigidita, trasformando l’appoggio all’Ucraina in un atto identitario più che in una strategia: nessuna idea propria, nessun canale autonomo, nessun rischio politico, solo impeccabile allineamento. Matteo Salvini, per anni pendolare tra simpatie per Mosca e patriottismo a intermittenza, non ha mai prodotto una posizione coerente; Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha incarnato alla perfezione la diplomazia italiana: educata, istituzionale, disinnescata, ininfluente. L’Italia non ha mai tentato una propria strada, non ha mai immaginato una mediazione, non ha mai cercato un ruolo europeo autentico: si è limitata a essere presente nelle foto, non nelle decisioni.
Il risultato è che l’Europa, nel suo insieme, non ha mai prodotto un piano di pace perché i suoi leader non hanno statura, coraggio o visione per farlo: ventisette paesi che non riescono a mettersi d’accordo su un decreto migratorio non possono certo inventare un processo di trattativa tra potenze nucleari. L’Europa preferisce aspettare che qualcuno negli Stati Uniti decida cosa è accettabile e cosa no, e poi ripetere quella linea come fosse un rosario militare.
Quando Trump ha detto “ci penso io”, i leader europei non hanno avuto paura che sbagliasse; hanno avuto paura che riuscisse anche solo ad aprire un varco. Perché quel varco avrebbe mostrato la loro irrilevanza, la loro dipendenza, la loro incapacità strutturale di immaginare una fine al conflitto senza che qualcuno lo faccia al posto loro. L’Europa predica pace da settant’anni, ma non sa costruirla. E così resta intrappolata nel suo paradosso: è il continente più colpito dalla guerra e l’unico che non riesce a immaginare un modo per fermarla se non aspettando che qualcun altro gliela consegni, magari in 24 ore, magari in 24 anni, purché non debba essere lei a provarci.
✍️ Testo e analisi di Max Ramponi
The Fakeless BLOG | NIENTE PADRONI • NIENTE FILTRI • NIENTE BALLE
✅ VERIFICATO FAKE FREE – Contenuti indipendenti e senza sponsor
© 2025 www.maxramponi.it | Tutti i diritti riservati | Riproduzione vietata.






Commenti