Perché in Italia anche tre chilometri di ponte diventano un confine invalicabile
- Max RAMPONI
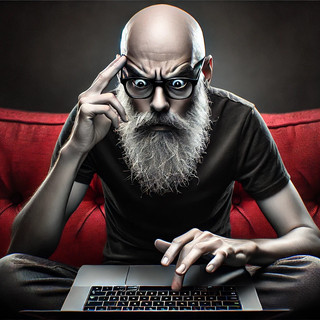
- 15 nov
- Tempo di lettura: 4 min

In ingegneria, tre chilometri non rappresentano un’impresa epica. Sono una misura quasi modesta, il tipo di distanza che altrove si affronta con pragmatismo e continuità. Eppure in Italia quei tremila metri diventano un labirinto di interrogativi, esitazioni e contraddizioni, quasi fossero una sfida alla nostra stessa capacità di funzionare come sistema. È un fenomeno che non ha radici tecniche: nasce nella cultura amministrativa, nella politica, nelle abitudini istituzionali. Il ponte è solo un pretesto: il vero tema è come il Paese si comporta quando deve costruire qualcosa che richiede una visione lunga.
Per capire la natura del problema basta guardare cosa è successo altrove. Il ponte dell’Øresund — Øresundsbron nel suo nome danese-svedese — collega Copenaghen a Malmö. Sedici chilometri tra viadotto, tunnel e un’isola artificiale creata dal nulla nel mezzo dello stretto. Due Stati diversi, due normative, due burocrazie, due lingue. Eppure il progetto ha seguito una linea retta: decisione politica, pianificazione, accordi binazionali, avvio dei lavori, completamento. Nessuno ha usato Øresundsbron come terreno di scontro permanente. Nessun governo l’ha impugnato per ribaltare la decisione del precedente. Non è diventato un trofeo, né una battaglia identitaria. È stato trattato per ciò che era: un’infrastruttura necessaria, da fare bene e in tempi certi.

Øresund Bridge from the air in September 2015 — vista aerea del collegamento stradale/ferroviario tra Danimarca e Svezia, noto come Ponte di Øresund (o Øresundsbron), lungo circa 16 km in totale; foto scattata nel settembre 2015. Crediti: foto di Folke Bendtsen / Wikimedia Commons. Licenza: CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale).
Mentre l’Europa settentrionale costruiva, in Asia si lavorava su scale ancora più monumentali. Il ponte Hong Kong–Zhuhai–Macau, con i suoi cinquantacinque chilometri di viadotti, tunnel sottomarini e isole artificiali, è un mostro ingegneristico affrontato in meno di dieci anni. Una struttura che attraversa corridoi marini affollati, zone soggette a tifoni, territori amministrativi diversi. Eppure la catena decisionale non si è inceppata. Là dove noi saremmo ancora a discutere la compatibilità di un pilone con una commissione paesaggistica, in Cina le fondamenta erano già state colate.

West section of Hong Kong–Zhuhai–Macau Bridge (20180902174105) — sezione occidentale del collegamento autostradale-marina tra Hong Kong, Zhuhai e Macao, nella regione del Delta del Fiume delle Perle, Cina. Crediti: foto di Wikimedia user Youngmonkey / Wikimedia Commons. Licenza: CC BY-SA 4.0 (Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale).
Poi c’è il Giappone, che offre l’esempio più vicino a noi dal punto di vista culturale, democratico e procedurale, ma con una differenza abissale nel modo di affrontare la complessità. Il sistema di ponti del Seto-Ohashi, quasi tredici chilometri sospesi su acque profonde e ventose, è nato in un’area in cui il rischio sismico è una certezza quotidiana. Il ponte Akashi Kaikyō, con la sua campata centrale di quasi due chilometri, è stato costruito mentre il Paese affrontava alcuni dei terremoti più violenti del secolo scorso. Durante i lavori, un sisma spostò addirittura le torri principali di quasi un metro, costringendo a riprogettare gli elementi centrali dell’opera senza interrompere il processo. In Giappone si costruisce dentro la difficoltà, non contro di essa.

Akashi Bridge / 明石海峡大橋 — ponte sospeso in Giappone, ripreso da un aeroplano nel dicembre 2005 — Foto di Kim Rötzel (caricata da Tysto) / Wikimedia Commons. Licenza: CC BY-SA 3.0 Unported (Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0).
È qui che emerge la differenza con l’Italia. La morfologia del nostro Paese è complessa, certo: montagne vive, zone sismiche, frane, suoli difficili. Ma non è una peculiarità esclusiva. Esistono territori più instabili, più imprevedibili, più ostili. Eppure altrove si costruisce. La vera differenza non è geologica: è istituzionale.
In Italia un ponte non deve attraversare solo un braccio di mare: deve attraversare una pianura sterminata di autorizzazioni, pareri, vincoli, ricorsi e incompatibilità. Ogni ente ha un potere di veto, pochi hanno un potere di avanzamento. Il risultato è un sistema in cui la tutela — legittima, doverosa — si è moltiplicata al punto da diventare un freno. La cultura amministrativa si è costruita sulla paura della firma, sulla difesa individuale, sulla preferenza per l’immobilità rispetto alla decisione. Dire “no” è sempre meno rischioso che dire “sì”.
I dati non fanno sconti. In Italia, il tempo medio necessario per autorizzare una grande opera supera spesso la decade. Non per costruire: per autorizzare. I cantieri, quando finalmente aprono, vanno avanti. Il blocco è tutto nella fase preliminare, ingolfata da una sequenza di verifiche che raramente comunicano tra loro. Di fronte a questo scenario, i nostri tre chilometri diventano improvvisamente un Everest amministrativo.
Poi c’è la politica, sempre instabile, sempre oscillante tra entusiasmi momentanei e ripensamenti improvvisi. Ogni cambio di governo porta con sé la tentazione di rimettere tutto in discussione. Le opere diventano argomenti di identità, simboli, vessilli, strumenti di comunicazione. Nascono più nei talk show che nei progetti esecutivi. In queste condizioni, persino un ponte relativamente breve diventa una vicenda generazionale.
A completare il quadro c’è un’altra verità: buona parte del patrimonio infrastrutturale italiano è antico. L’urgenza di intervenire su ciò che già esiste — ponti, viadotti, gallerie — assorbe risorse, energie e tempo. La manutenzione continua è un dovere che non lascia spazio alla costruzione del nuovo, soprattutto quando il nuovo richiede processi lunghi e dispendiosi.
Il problema, dunque, non è tecnico. Non lo è mai stato. L’Italia sa costruire: quando decide di farlo, lo fa bene. Ma non decide quasi mai in modo lineare. Non protegge chi decide. Non garantisce continuità a ciò che avvia. E così anche tre chilometri, la distanza più semplice per gli ingegneri, diventano un abisso per le istituzioni.
Finché questo nodo non verrà sciolto, continueremo a guardare Øresundsbron, Seto-Ohashi, Akashi Kaikyō, Hong Kong–Zhuhai–Macau come opere di un mondo diverso. Non perché siano impossibili da replicare, ma perché per farlo servirebbe una capacità di governare i processi che oggi non possediamo più. La distanza fisica, in fondo, non è nulla. È la distanza amministrativa che non riusciamo mai ad attraversare.
✍️ Testo e analisi di Max Ramponi
✅ VERIFICATO FAKE FREE – Contenuti indipendenti e senza sponsor
© 2025 maxramponi.it | Tutti i diritti riservati | Riproduzione vietata.






Commenti